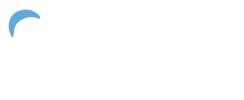Secondo i racconti di molteplici autori posti in diverse epoche, il mito di Partenope si colloca con l’origine della città di Napoli, mito che si intreccia con la storia, la leggenda e il viaggio di Ulisse.
Tre almeno, sono le versioni che ci sono state tramandate:
Partenope (in greco “Vergine”) era una fanciulla che viveva in Grecia, in un paesino che si affacciava sul Mar Jonio. Dotata di grande fantasia, amava stare per ore su uno scoglio, sognando di visitare altri paesi. Ella era innamorata del giovane Cimone, ma il loro amore era contrastato dal padre che l’aveva promessa ad Eumeo. Un giorno i due innamorati , decisero di fuggire e dopo varie peripezie, approdarono sulle coste italiche. Al loro arrivo sulla nuova terra, la natura cominciò a produrre una florida e lussureggiante vegetazione. La voce si sparse in Fenicia, in Grecia e in Egitto, così molti popoli, caricati i loro averi sulle imbarcazioni, partirono alla volta di questa meravigliosa terra, dove costruirono capanne prima sulla collina, poi man mano in pianura e sulla costa. Intanto Partenope era diventata madre di 12 figli, amata e rispettata per la pietà e la generosità che aveva dimostrato verso chiunque approdasse su quelle terre, divenne la Signora dei partenopei. La pace regnò per moltissimo tempo, perché tutti rispettavano quanto lei stabiliva per legge, al punto che il popolo si distinse per l’alto grado di civiltà raggiunto.
Una seconda versione, forse quella più cara ai partenopei, racconta di tre sirene, figlie del dio-fiume Acheloo e della musa Melpomene. Le tre sorelle pare fossero delle musiciste squisite: Ligia, che suonava la lira, Leucosia, che suonava il flauto e la sirena Partenope che cantava con la sua splendida voce. Le Sirene ci vengono descritte come creature infernali di aspetto femminile e suadente, con corpo di uccello (nell’antichità) o di pesce (in altre varianti) dotate di un potere malefico: sedurre le orecchie dei viaggiatori al fine di ucciderli. Il loro potere avrebbe avuto fine solo se un uomo le avesse respinte, condannandole per la vergogna, al suicidio. Fu quello che accadde al passaggio di Ulisse. Leucosia si lasciò morire presso capo Licosa vicino Paestum, Ligia si spinse sulle coste del Bruzio in Calabria e Partenope fu trasportata dalle onde a Megaride, nel Golfo di Napoli. A questo punto la versione fin’ora raccontata, si divide in due epiloghi: nel primo, il corpo della sirena fu trovato dalla popolazione locale che le dedicò un sepolcro nella zona fra Megaride e Pizzofalcone, nei pressi del fiume Sebeto (il fiume antico che si presume, scorra ancora nel sottosuolo) e a lei le si attribuirono grandi onorificenze alimentando il culto matriarcale di Partenope. Nel secondo epilogo, il corpo di Partenope, una volta approdato sull’isolotto di Megaride, si dissolse trasformandosi nella morfologia del paesaggio partenopeo, il cui capo è appoggiato ad oriente, sull’altura di Capodimonte ed il piede, ad occidente, verso il promontorio di Posillipo.
Nell’Ottocento, invece, si diffuse la terza versione della storia: quella dell’amore della Sirena per il centauro Vesuvio. Ciò avrebbe scatenato la gelosia di Zeus che li punì trasformando lui in un vulcano e lei nella città di Napoli.
E se quest’ultima fosse “la versione reale” vorrebbe dire che anche la più grande calamità che incombe su questa terra e sulla sua gente è frutto dell’amore. Un amore impossibile, osteggiato, tormentato e che, pertanto, propriamente merita di trovarsi “all’origine di ogni cosa”, alla base di tutto.
Anche di quel sentimento che da millenni vive ancorato al nome di Partenope.